Le visite dei pontefici

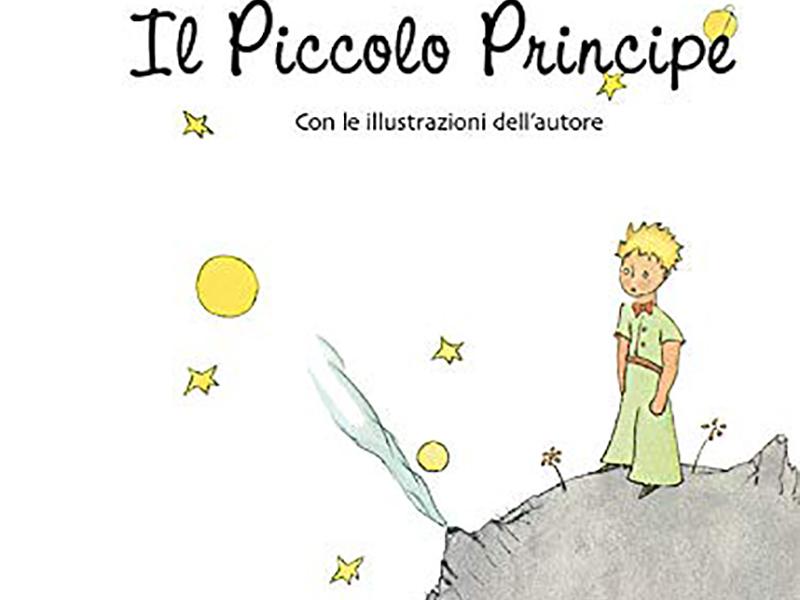
Come diceva sant’Ignazio non è l’abbondanza della scienza che soddisfa l’anima
Ora che lentamente inizia a placarsi il clamore mediatico, ci permettiamo di fare una riflessione su questo tempo di cura, che ci piacerebbe divenga tempo di cura integrale. Il pericolo di un contagio incontrollato ha dettato tempi e ritmi, che sono quelli propri di un’emergenza e, come anche altri hanno fatto notare, è prevalso un linguaggio bellico per una vicenda che aveva invece bisogno di parole di cura. Sicuramente una pandemia è di per sé una grande tragedia, anche se epidemie simili hanno costellato la storia dell’umanità. Almeno una ventina di esse, negli ultimi 3000 anni della nostra storia, sono state responsabili di oltre 500 milioni di morti o forse anche molti di più.
Ognuna di queste pestilenze è stata anche portatrice di grandi rivolgimenti sociali, politici, scientifici e culturali, nel bene e nel male. Attraverso il dolore si sono raggiunte delle conquiste, ma si sono udite anche “urla e furore”, per citare un titolo del Nobel per la letteratura William Faulkner. Cosa ci aspetterà dopo questa tempesta? Si dicono le cose più diverse, prendendo ad esempio due personaggi che “fanno opinione”, traendo conclusioni anche opposte. Secondo il cantautore, scrittore e poeta Francesco Guccini non saremo migliori: «È la storia che non insegna o sono gli uomini che non imparano? Tutte due le cose. È nella natura umana il dimenticarsi presto delle tragedie passate per riprendere la vita di sempre».
All’opposto, il regista cinematografico David Lynch sostiene che «saremo tutti più spirituali e gentili». Crediamo invece ancora una volta nel primato della libertà dell’essere umano, ci troveremo probabilmente a un bivio e toccherà a noi di nuovo scegliere e lo ha perfettamente espresso Papa Francesco: dopo la pandemia sarà necessaria una scelta tra «il bene della gente e cadere nel sepolcro del dio Denaro». Una terza via non è data, o veramente umani o precipitare nella disumanità perché «Quando non serviamo il Signore Dio, serviamo il signore denaro».
La pandemia da Sars-cov2 ha comunque un primato: è la prima pandemia insorta nell’era dei social. È una pestilenza che ha flagellato una società “invecchiata”, responsabile di «guerre e ingiustizie planetarie» come ci ha ricordato il Papa in quella indimenticabile piazza San Pietro. È la pandemia che ha paralizzato una società abituata a correre (la società della mobilità costretta all’immobilità, per usare una frase a effetto del sociologo Edgard Morin). È la pestilenza che ha ricordato a tutti che siamo mortali ma nonostante questo abbiamo voluto “militarizzare” questo evento per relegarlo di nuovo all’eccezionalità e non prendere atto della nostra finitudine.
La prima epidemia della storia in cui il lutto condiviso non è stato possibile, in cui si sviluppano nuovi concetti di vita e di morte, quelli del web, in cui occorrerà interrogarci su quello che succede al profilo social di una persona che muore, su quali saranno le nuove frontiere del lutto (e soprattutto del lutto patologico) dopo le macerie di questo cataclisma.
Ma se la speranza deve sempre contraddistinguere il cristiano, dobbiamo e possiamo estrarre alcuni insegnamenti da questa “tempesta”, per imparare a prenderci cura degli altri, con un approccio che ci piace chiamare “cura integrale”, mutuandola dal concetto di “sviluppo umano integrale” a cui si è molto dedicato questo pontificato. Il mondo appare disorientato, la gente comune è alla ricerca di senso, occorre offrire strumenti per cogliere quanto stiamo vivendo come un’occasione preziosa.
Ogni considerazione dovrebbe partire dalla certezza che la Provvidenza divina ha incessantemente cura di noi, e lo sguardo di fede dovrebbe aiutarci a intravedere anche in eventi drammatici uno spazio creativo dello Spirito Santo, fino a indurci a cogliere perfino nell’impossibilità di partecipare fisicamente ai sacramenti, sorte condivisa anche dai fratelli di altre religioni per i loro culti, un’occasione di crescita interiore. Un antico filosofo citato da tanti cristiani, Epitteto, diceva che i fatti non sono di per sé positivi o negativi, siamo noi che liberamente possiamo interpretarli.
A maggior ragione la nostra fede nel Signore e salvatore ci dona una possibilità in più: non solo sta a noi interpretarli, ma abbiamo fiducia che scegliendo la lettura positiva dei fatti saremo più vicini alla verità poiché dietro le nostre vicende si nasconde una mano divina e amorevole. In molte nazioni la quasi totalità dei fedeli di tutte le religioni e confessioni non ha potuto partecipare fisicamente per lungo tempo ai sacramenti, ai riti religiosi, alle esequie, ai momenti comunitari legati al proprio credo. Questa esperienza, per quanto dolorosa, può sollecitarci a cercare altre vie per vivere spiritualmente tutto quanto desideriamo, sia come cristiani che come esseri umani. E soprattutto ci esorta a «fare nuove tutte le cose» (cfr. Ap 21, 5), secondo la sollecitazione dello Spirito. Il primo insegnamento è relativo al silenzio.
La civiltà odierna, e frequentemente anche noi cristiani come cittadini di questo mondo, percepisce il silenzio come minaccia e viene spesso riempito di parole, suoni, immagini attingendo a piene mani a quello che ci propinano televisione e internet. Vivere interiormente e nel silenzio i momenti sacri che sono stati “rapiti” dalla pandemia potrebbe farci scoprire quello che hanno sperimentato tutti i grandi mistici: la parola di Dio per noi scaturisce nel silenzio. Ce lo ricorda con parole poetiche anche un laico come Stefano Benni nel suo “La grammatica di Dio”: «Non si dovrebbe parlare di Dio. Non conosciamo la sua lingua. Possiamo soltanto ascoltare.
Come l’incanto di una musica lontana, nel cuore della notte». A maggior ragione se ci si accorge di essere vittime disarmate delle proprie parole di fronte al mistero della vita e della morte, del senso della sofferenza, dell’esistenza di un Dio; il silenzio potrebbe essere un vero atto di giustizia da compere. Il secondo insegnamento è sull’invisibile. Ancora una volta la penna poetica di qualche autore ci suggerisce qualcosa a cui noi cristiani possiamo attribuire ancora più valore.
Il Piccolo Principe insegna che «l’essenziale è invisibile agli occhi». Recitiamo infatti incessantemente nel Credo che Lui ha creato le cose visibili e invisibili. In un mondo radicalmente ed esistenzialmente materialista non potremmo come cristiani cogliere l’occasione di testimoniare a tutti che l’invisibile, sempre e comunque, non può essere “scippato” da nessuno? Forse un serio esame di coscienza ci potrebbe svelare che non viviamo a sufficienza di cose invisibili e la Provvidenza ce ne dona ora l’occasione. Un’altra riflessione è sulla vita comunitaria.
Le restrizioni delle relazioni sociali richieste dai decreti per il contenimento del coronavirus, potrebbero invitarci a scoprire la dimensione invisibile e silenziosa del nostro essere Chiesa, del nostro essere membra del Corpo mistico di Cristo ma anche e soprattutto del nostro essere umani? È solo una privazione o una possibilità nuova e preziosa? Se rileggessimo l’impossibilità a essere presenti fisicamente ai nostri riti, e questo potrebbe riguardare anche i fratelli di altre religioni, come un invito a vivere la religiosità comunitaria più interiormente che esteriormente?
Approfittiamo di questi giorni di attesa per prepararci al prossimo ritorno delle celebrazioni religiose praticando tanta preghiera silenziosa, sperimentando la sensazione di comunione che questa può donare. San Giovanni Paolo II parlando della preghiera del cuore in un Angelus del 1996 diceva: «Ma la preghiera in Oriente, come in Occidente, conosce, oltre a quella liturgica, tante altre espressioni. Con una speciale predilezione gli autori spirituali suggeriscono la preghiera del cuore, che consiste nel saper ascoltare, in un silenzio profondo e accogliente, la voce dello Spirito...
L’uomo è aiutato così a sentire la presenza del Salvatore in tutto ciò che incontra, e si sperimenta amato da Dio nonostante le proprie debolezze. Pur recitata nell’intimo, essa ha una misteriosa irradiazione comunitaria». Tutto quanto stiamo vivendo sul piano della pratica religiosa potrebbe anche essere compreso come un invito della Provvidenza a entrare in una dimensione più mistica, per accogliere il noto e forse profetico invito del gesuita e teologo K. Rahner: «Il cristiano del futuro o sarà mistico o non sarà neppure cristiano».
Infine, crediamo che la pandemia ci costringa a una dura prova, ma se la Provvidenza l’ha permessa (rimarchiamo, “permessa”, non crediamo che Dio voglia ciò che ci fa soffrire) è forse davvero perché attraverso di essa possiamo imparare cose nuove, e tra cui la più preziosa potrebbe essere la definitiva percezione della nostra sostanziale impotenza. In un mondo ubriacato da deliri di onnipotenza tutti abbiamo bisogno, noi compresi, di accogliere umilmente la propria impotenza per poter finalmente lasciare spazio solo all’Onnipotente. E se Lui lo è, ed è anche amore, di cosa dobbiamo temere?
Per concludere ci domandiamo: in tutto quanto stiamo vivendo che consolazione possiamo offrire alle decine di migliaia di morti in Italia in questo tempo di isolamento in cui nessuno ha potuto avere vicino i propri cari se ospedalizzato? E agli innumerevoli altri defunti in condizioni simili nel resto del mondo? Sì, perché nell’ebbrezza della retorica bellica ci siamo dimenticati che anche senza coronavirus molti altri morivano per altre patologie, per incidenti, per vecchiaia, per violenza. Anche essi quasi sempre senza cura spirituale e umana: senza cura integrale. Potremmo offrire una consolazione grande se accostassimo le loro morti a quella di Cristo. Ci ha molto colpiti in questa pandemia, la possibile similitudine fra la morte per infezione da Sars-Cov2 e la morte di Gesù narrata dai Vangeli: come Gesù, le persone muoiono di un’agonia lunga, con gravi difficoltà respiratorie, fra sofferenze spesso inaudite e inascoltate, nella solitudine poiché lontani dai propri affetti, timorosi di essere da questi abbandonati...
Anche Gesù «gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni? [...] Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mc 15, 34). Per amore ha vissuto prima di noi e per noi ogni desolazione e in questa pandemia ci appare di nuovo con evidenza. Infine, ci ha colpito più di tutto lo stesso destino terreno condiviso tra loro e Gesù: esequie mai avvenute, persone morte che non si sa bene dove siano state portate, come manifesta la triste domanda che pone la Maddalena (Gv 20, 13): «Hanno portato via il mio Signore, ma non so dove l’hanno posto...». Possiamo e vogliamo augurare a tutti questi defunti e quelli dei giorni a venire che possano anche loro esclamare alla fine lo stesso “Rabbunì”, quasi gridato dalla Maddalena, quando incontreranno Gesù risorto che non avevano prima riconosciuto.
(Osservatore Romano, di GUIDALBERTO BORMOLINI, Sacerdote, presidente di Tutto è vita Onlus, e BRUNO MAZZOCHI, Medico, ex direttore Hospice di Grosseto e responsabile della Società cure palliative Toscana)
Cari amici la rivista San Francesco e il sito sanfrancesco.org sono da sempre il megafono dei messaggi di Francesco, la voce della grande famiglia francescana di cui fate parte.
Solo grazie al vostro sostegno e alla vostra vicinanza riusciremo ad essere il vostro punto di riferimento. Un piccolo gesto che per noi vale tanto, basta anche 1 solo euro. DONA


